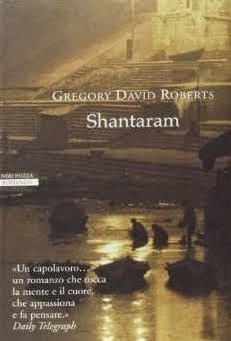Non sono attratto dai racconti brevi perchè solitamente è difficile descrivere in poche pagine personaggi e situazioni in modo che risultino coinvolgenti e convincenti. Donne dagli occhi grandi è un po' un'eccezione ed il merito dell'autrice è proprio quello di creare storie semplici ed intense. Non tutte le quattro storie narrate sono allo stesso livello: quella che trascrivo di seguito è probabilmente la migliore.
è un po' un'eccezione ed il merito dell'autrice è proprio quello di creare storie semplici ed intense. Non tutte le quattro storie narrate sono allo stesso livello: quella che trascrivo di seguito è probabilmente la migliore.
La zia Daniela s'innamorò come s'innamorano sempre le donne intelligenti: come un'idiota. Lo aveva visto arrivare un mattino, le spalle erette e il passo sereno, e aveva pensato: «Quest'uomo si crede Dio». Ma dopo averlo sentito raccontare storie di mondi lontani e di passioni sconosciute, si innamorò di lui e delle sue braccia come se non parlasse latino sin da bambina, non avesse studiato logica e non avesse sorpreso mezza città imitando i giochi poetici di Góngora e di suor Juana Inés de la Cruz come chi risponde ad una filastrocca durante la ricreazione. Era tanto colta che nessun uomo voleva mettersi con lei, per quanto avesse occhi di miele e labbra di rugiada, per quanto il suo corpo solleticasse l'immaginazione risvegliando il desiderio di vederlo nudo, per quanto fosse bella come la Madonna del Rosario. Gli uomini avevano paura di amarla, perchè c'era qualcosa nella sua intelligenza che suggeriva sempre un disprezzo per il sesso opposto e le sue ricchezze.
Ma quell'uomo che nulla sapeva di lei e dei suoi libri le si accostò come a chiunque altra. Allora la zia Daniela lo dotò di un'intelligenza abbagliante, una virtù angelica e un talento d'artista. Il suo cervello lo guardò in tanti modi che in capo a dodici giorni credette di conoscere cento uomini.
Lo amò convinta che Dio possa aggirarsi tra i mortali, abbandonata con tutta se stessa ai desideri e alle stramberie di un uomo che non aveva mai avuto intenzione di rimanere e non aveva mai capito neppure uno di tutti i poemi che Daniela aveva voluto leggergli per spiegare il suo amore.
Un giorno così com'era venuto, se ne andò senza neppure salutare. Non ci fu allora in tutta l'intelligenza della zia Daniela una sola scintilla in grado di spiegarle ciò che era successo.
Ipnotizzata da un dolore senza nome né destino, diventò la più stupide delle stupide. Perderlo fu un dolore lungo come l'insonnia, una vecchiaia di secoli, l'inferno.
Per pochi giorni di luce, per un indizio, per gli occhi d'acciaio e di supplica che le aveva prestato una notte, la zia Daniela sotterrò la voglia di vivere e cominciò a perdere lo splendore della pelle, la forza delle gambe, l'intensità della fronte e delle viscere.
Nel giro di tre mesi divenne quasi cieca, le crebbe una gobba sulla schiena e dovette succedere qualcosa anche al suo termostato interno, perché, nonostante indossasse anche in pieno sole calze e cappotto, batteva i denti dal freddo come se vivesse al centro stesso dell'inverno. La portavano fuori a prendere aria come un canarino. Le mettevano accanto frutta e biscotti da becchettare, ma sua madre si portava via il piatto intatto mentre Daniela rimaneva muta, nonostante gli sforzi che tutti facevano per distrarla.
All'inizio la invitavano in strada, per vedere se, guardando i colombi e osservando la gente che andava e veniva, qualcosa in lei cominciasse a dare segni di attaccamento alla vita. Provarono di tutto. Sua madre se la portò in Spagna e le fece girare tutti i locali sivigliani di flamenco senza ottenere da lei nulla più di una lacrima, una sera in cui il cantante era allegro. La mattina seguente inviò un telegramma a suo marito:«Comincia a migliorare, ha pianto un secondo». Era diventata come un arbusto secco, andava dove la portavano e appena poteva si lasciava cadere sul letto come se avesse lavorato ventiquattr'ore di seguito in una piantagione di cotone. Alla fine non ebbe più forze che per gettarsi su una sedia a dire a sua madre:«Ti prego, andiamocene a casa».
Quando tornarono, la zia Daniela camminava a stento, e da allora non volle più alzarsi dal letto. Non voleva neppure lavarsi, né pettinarsi, né fare pipì. Un mattino non riuscì neppure ad aprire gli occhi.
«E' morta!», sentì esclamare intorno a sé, e non trovò la forza di negarlo.
Qualcuno suggerì a sua madre che un tale comportamento fosse un ricatto, un modo di vendicarsi degli altri, una posa da bambina viziata che, se di colpo avesse perso la tranquillità di una casa sua e la pappa pronta, si sarebbe data da fare per guarire da un giorno all'altro. Sua madre fece lo sforzo di crederci e seguì il consiglio di abbandonarla sul portone della cattedrale. La lasciarono lì una notte con la speranza di vederla tornare, affamata e furiosa, com'era stata un tempo. La terza notte la raccolsero dal portone e la portarono in ospedale tra le lacrime di tutta la famiglia.
All'ospedale andò a farle visita la sua amica Elidé, una giovane dalla pelle luminosa che parlava senza posa e che sosteneva di saper curare il mal d'amore. Chiese che le permettessero di prendersi cura dell'anima e dello stomaco di quella naufraga. Era una creatura allegra e attiva. Ascoltarono il suo parere. Secondo lei, l'errore nella cura della sua intelligente amica consisteva nel consiglio di dimenticare. Dimenticare era una cosa impossibile. Quel che bisognava fare era imbrigliare i suoi ricordi perchè non la uccidessero, perchè la obbligassero a continuare a vivere.
I genitori ascoltarono la ragazza con la stessa indifferenza che ormai suscitava in loro qualsiasi tentativo di curare la figlia. Davano per scontato che non sarebbe servito a nulla, ma autorizzarono il tentativo come se non avessero ancora perso la speranza, che ormai avevano perso.
Le misero a dormire nella stessa stanza. Pasando davanti a quella porta, in qualsiasi momento, si udiva l'ifaticabile voce di Elidé parlare dell'argomento con la stessa ostinazione con la quale un medico veglia un moribondo. Non stava zitta un minuto. Non le dava tregua. Un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra.
«Come hai detto che erano le sue mani?», chiedeva.
Se la zia Daniela non rispondeva, Elidé l'attaccava su un altro fronte.
«Aveva gli occhi verdi? Castani? Grandi?».
«Piccoli», rispose la zia Daniela, aprendo bocca per la prima volta dopo un mese.
«Piccoli e torbidi?», domandò Elidé.
«Piccoli e fieri», rispose la zia Daniela, e ricadde nel suo mutismo per un altro mese.
«Era sicuramente del Leone. Sono così, i Leoni», diceva la sua amica tirando fuori un libro sui segni zodiacali. Le leggeva tutte le nefandezze che un Leone può commettere. «E poi sono bugiardi. Ma tu non devi lasciarti andare, sei un Toro: sono forti le donne del Toro».
«Di bugie sì che ne ha dette», le rispose Daniela una sera.
«Quali? Non te ne scordare! Perché il mondo non è tanto grande da non incontrarlo mai più, e allora gli ricorderai le sue parole: una per una, quelle che ti ha detto e quelle che ha fatto dire a te».
«Non voglio umiliarmi».
«Sarai tu a umiliare lui. Sarebbe troppo facile, seminare parole e poi filarsela».
«Le sue parole mi hanno illuminata!», lo difese la zia Daniela.
«Si vede, come ti hanno illuminata!», diceva la sua amica, arrivate a questo punto.
Dopo tre mesi ininterrotti di parole la fece mangiare come Dio comanda. Non si rese neppure conto di come fosse successo. L'aveva portata a fare una passeggiata in giardino. Teneva sottobraccio una cesta con frutta, pane, burro, formaggio e tè. Stese una tovaglia sull'erba, tirò fuori la roba e continuò a parlare mettendosi a mangiare senza offrirle nulla.
«Gli piaceva l'uva», disse l'ammalata.
«Capisco che ti manchi».
«Sì» disse la zia Daniela, portandosi alla bocca un grappolo d'uva. «Baciava divinamente. E aveva la pelle morbida, sulla schiena e sulla pancia».
«E com'era... sai di che cosa parlo», disse l'amica, come se avesse sempre saputo che cosa la torturava.
«Non te lo dico», rispose Daniela ridendo per la prima volta dopo mesi. Mangiò poi pane e burro, formaggio e tè.
«Bello?», chiese Elidé.
«Sì», rispose l'ammalata, ricominciando a essere se stessa.
Una sera scesero a cena. La sia Daniela indossava un vestito nuovo e aveva i capelli lucidi e puliti, finalmente liberi dalla treccia polverosa che non si era pettinata per tanto tempo.
Venti giorni più tardi, le due ragazze avevavo ripassato tutti i ricordi da cima a fondo, fino a renderli banali. Tutto ciò che la zia Daniela aveva cercato di dimenticare, sforzandosi di non pensarci, a furia di ripeterlo divenne per lei indegno di ricordo. Castigò il suo buon senso sentendosi raccontare una dopo l'altra le centoventimila sciocchezze che l'avevano resa felice e disgraziata.
«Ormai non desidero più neppure vendicarmi», disse un mattino a Elidé. «Sono stufa marcia di questa storia».
«Come? Non mi ridiventare intelligente, adesso», disse Elidé. «Questa è sempre stata una questione di ragione offuscata: non vorrai trasformarla in qualcosa dilucido? Non sprecarla, ci manca la parte migliore: dobbiamo ancora andare a cercare quell'uomo in Europa e in Africa, in Sudamerica e in India, dobbiamo trovarlo e fare un baccano tale da giustificare i nostri viaggi. Dobbiamo ancora visitare la Galleria Pitti, vedere Firenze, innamorarci a Venezia, gettare una moneta nella Fontana di Trevi. Non vogliamo inseguire quell'uomo che ti ha fatto innamorare come un'imbecille e poi se n'è andato?».
Avevamo progettato di girare il mondo in cerca del colpevole, e questa storia che la vendetta non fosse più imprescindibile nella cura della sua amica era stata un brutto colpo per Elidé. Dovevano perdersi per l'India e il Marocco, la Bolivia e il Congo, Vienna e soprattutto l'Italia. Non aveva mai pensato di trasformarla in un essere razionale dopo averla vista paralizzata e quasi pazza quattro mesi prima.
«Dobbiamo andare a cercarlo. Non mi diventare intelligente prima del tempo», le diceva.
«E' arrivato ieri», le rispose le rispose la zia Daniela un giorno.
«Come lo sai?»
«L'ho visto. Ha bussato al mio balcone come una volta».
«E che cosa hai provato?»
«Niente».
«E che cosa ti ha detto?»
«Tutto».
«E che cosa gli hai risposto?»
«Ho chiuso la finestra».
«E adesso?», domandò la terapista.
«Adesso sì ce ne andiamo in Italia: gli assenti si sbagliano sempre».
Read more...
 Donna di Porto Pim
Donna di Porto Pim