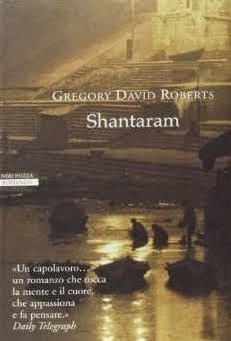Non capita spesso di trovare un libro che una volta finito lo si rilegge dall'inizio per dare un valore compiuto e meglio definito all'intera vicenda. Il senso di una fine di Barnes è uno di questi rari casi. Costruito come un thriller, con un paio di colpi di scena importanti, lo si ripercorre a ritroso per capire se si è perso qualcosa per strada, si è sorvolato su un indizio, un dettaglio che sembrava irrilevante e invece non lo era.
di Barnes è uno di questi rari casi. Costruito come un thriller, con un paio di colpi di scena importanti, lo si ripercorre a ritroso per capire se si è perso qualcosa per strada, si è sorvolato su un indizio, un dettaglio che sembrava irrilevante e invece non lo era.
La storia è narrata dal protagonista sessantenne, ormai in pensione, che ha vissuto una vita partita con grandi attese ma che si è poi rivelata mediocre, per sua stessa ammissione. Si è sempre lasciato trascinare dalle vicende invece di indirizzare il corso degli eventi, e in tanti momenti non ha capito le ragioni che c'erano dietro atteggiamenti e situazioni. E' ora costretto a ricomporre pezzi della sua adolescenza, dei momenti vissuti a scuola, con gli amici, con il primo amore per dare significato ad una lettera e ad una inaspettata eredità. Il libro scorre benissimo merito di una scrittura di altissimo livello. Si presta a due letture: una più diretta, che segue il corso degli eventi, l'altra più profonda, se ci si sofferma sulle digressioni che affrontano vari temi (il tempo, l'amicizia, il suicidio, la memoria, la giovinezza, la vecchiaia, la storia). Di notevole valore anche il messaggio che trasuda da tutto il libro: il passato di ognuno di noi non esiste nella sua versione unica e definita perchè sottoposto ad un costante processo di revisione da parte della memoria.
L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è l'imprevedibile finale che è così sconcertante da sembrare un po' forzato.
Viviamo nel tempo; il tempo ci forgia e ci contiene, eppure non ho mai avuto la sensazione di capirlo fino in fondo. Non mi riferisco alle varie teorie su curvature e accelerazioni né all’eventuale esistenza di dimensioni parallele in un altrove qualsiasi. No, sto parlando del tempo comune, quotidiano, quello che orologi e cronometri ci assicurano scorra regolarmente: tic tac, tic toc. Esiste al mondo una cosa piú ragionevole di una lancetta dei secondi? Ma a insegnarci la malleabilità del tempo basta un piccolissimo dolore, il minimo piacere. Certe emozioni lo accelerano, altre lo rallentano; ogni tanto sembra sparire fino a che in effetti sparisce sul serio e non si presenta mai piú. Non sono particolarmente interessato ai miei anni di scuola, non ne ho affatto nostalgia. Ma è a scuola che tutto è cominciato, perciò mi toccherà tornare brevemente su certi eventi marginali ormai assurti al rango di aneddoti, su alcuni ricordi approssimati che il tempo ha deformato in certezze. Se da un lato a questo punto non posso garantire sulla verità dei fatti, dall’altra posso attenermi alla verità delle impressioni che i fatti hanno prodotto. È il meglio che posso offrire.
[...]
In quei giorni immaginavamo noi stessi come prigionieri dentro un recinto, in attesa di essere liberati nel pascolo delle nostre esistenze. Quando fosse giunto il momento, la vita, e il tempo stesso, avrebbero subíto un’accelerazione. Come avremmo potuto sapere che in effetti le nostre vite erano già cominciate, che alcuni vantaggi ce li eravamo accaparrati e che qualche danno era già stato inflitto? E che, per di piú, ci avrebbero solo liberati dentro un recinto piú grande i cui limiti avremmo in principio faticato a riconoscere?
Frattanto, avevamo fame di libri e di sesso, eravamo anarchici e meritocratici. Ogni sistema sociale e politico ci sembrava corrotto, ma ci astenevamo dal considerare un’alternativa qualsiasi diversa dal caos edonistico. Adrian, tuttavia, ci esortava a credere nell’applicazione del pensiero alla realtà, secondo il principio che le idee dovessero fare da guida all’azione. In precedenza, il filosofo del gruppo era stato Alex. Aveva letto libri ignoti agli altri due e poteva uscirsene all’improvviso in dichiarazioni come: «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Io e Colin ponderavamo l’idea in silenzio per un momento, poi riprendevamo il discorso, con un sorrisetto. Ora però, l’arrivo di Adrian aveva sfrattato Alex dalla posizione occupata, o meglio, aveva offerto a noi due un candidato diverso per il ruolo del filosofo. Se Alex aveva letto Russell e Wittgenstein, Adrian conosceva Camus e Nietzsche. Io mi ero letto George Orwell e Aldous Huxley; Colin Dostoevskij e Baudelaire. E si tratta solo in parte di una caricatura.
[...]
– Potremmo ad esempio partire dalla domanda solo in apparenza semplice, Che cos’è la Storia? Qualche idea, Webster?
– La storia è fatta delle menzogne dei vincitori, – risposi un po’ troppo fulmineo.
– Sí, temevo che avrebbe detto cosí. Non dimentichi comunque che è fatta anche delle illusioni dei vinti. Simpson?
Colin era piú preparato di me. – La storia è come un panino con la cipolla cruda, signore.
– In che senso?
– Perché non fa che ripetersi, signore. Torna su. L’abbiamo constatato mille volte quest’anno. Sempre la solita solfa, lo stesso pendolo tra tirannia e ribellione, guerra e pace, prosperità e depauperamento.
– Tutt’altro che poco per un panino, non trova?
Ridemmo molto piú del necessario, in preda all’euforia da fine semestre.
– Finn?
– «La storia è quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze della documentazione».
– Ma davvero? Questa dove l’ha trovata?
– Lagrange, signore. Patrick Lagrange. Un francese.
– Lo si poteva arguire. Sarebbe tanto gentile da offrirci un esempio?
– Il suicidio di Robson, signore.
Si sentí in aula un notevole risucchio di fiato e qualcuno voltò d’istinto la testa. Hunt tuttavia, come gli altri insegnanti, accordava a Adrian un’indulgenza speciale. Chiunque di noi si azzardasse a provocare veniva liquidato come affetto da puerile cinismo, un altro vizio che avremmo superato crescendo. Le sfide di Adrian, invece, erano accolte come un’anomala ricerca della verità.
– Che c’entra questo con il discorso in questione?
– Si tratta di un evento storico, signore, seppure marginale. In compenso è recente. Perciò non dovrebbe essere difficile inserirlo nella storia. Sappiamo che è morto, sappiamo che aveva una ragazza, sappiamo che lei è incinta – o lo era. Che altro abbiamo? Un unico documento scritto, un messaggio di addio che dice «Scusami, mamma» – almeno secondo la versione di Brown. Esiste ancora il biglietto? È stato distrutto? Robson aveva altri possibili moventi o ragioni, oltre a quelli ovvi? In che condizioni mentali si trovava? Possiamo essere certi che il figlio fosse suo? No, non possiamo saperlo, nemmeno a cosí poca distanza dai fatti. Perciò, come potrebbe chiunque scrivere la vicenda di Robson tra cinquant’anni quando i suoi genitori saranno morti e la sua ragazza sarà scomparsa e non vorrà comunque ricordarsi di lui? Capisce il problema, signore?
Ci girammo tutti a guardare Hunt, chiedendoci se quella volta Adrian non avesse davvero esagerato. Anche solo la parola «incinta» sembrava aleggiare su di noi come polvere di gesso. Quanto poi alla temeraria ipotesi di una paternità alternativa, di Robson in veste di Liceale Cornuto… Dopo un momento, il professore rispose.
– Capisco il problema, Finn. Ma credo che lei sottovaluti la storia. E pure gli storici. Proviamo a supporre, per amor di dibattito, che il povero Robson si riveli un soggetto di interesse storico. Da sempre gli storici devono vedersela con la mancanza di prove chiare dei fatti. Ci sono abituati. Non dimentichi inoltre che, nel caso specifico, ci sarebbe stata un’inchiesta e perciò un rapporto del coroner. È possibile inoltre che Robson tenesse un diario, o scrivesse lettere, facesse telefonate il cui contenuto sarebbe stato registrato. I suoi genitori avranno risposto alle condoglianze che hanno ricevuto. E a cinquant’anni da oggi, con le attuali aspettative di vita, parecchi suoi compagni di scuola saranno ancora rintracciabili per un’intervista. Il problema potrebbe rivelarsi meno scoraggiante di quanto lei immagini.
– Niente potrà però ovviare alla mancata testimonianza di Robson.
– Per certi versi, no. Ma d’altra parte gli storici sono costretti a considerare con una buona dose di scetticismo la dichiarazione di individui coinvolti nell’evento. È spesso la testimonianza rilasciata con un occhio al futuro la meno attendibile.
– Se lo dice lei, signore.
– Le condizioni mentali delle persone possono spesso essere dedotte dai loro gesti. È raro che un tiranno che vuol far eliminare un nemico spedisca una richiesta redatta di suo pugno.
– Se lo dice lei, signore.
– Infatti, lo dico io.
Fu proprio questo lo scambio di battute tra loro? Quasi certamente no. Resta comunque il ricordo piú preciso che conservo di quello scambio.
[...]
– Secondo Camus il suicidio è l’unica vera questione filosofica.
– Se si escludono l’etica, la politica, l’estetica, la natura del reale e compagnia bella –. La controbattuta di Alex non era del tutto peregrina.
– L’unica vera questione, ho detto. Quella essenziale, da cui dipendono tutte le altre.
Una lunga disamina del suicidio di Robson ci portò a concludere che lo si potesse considerare filosofico in un senso aritmetico del termine: destinato a incrementare di un’unità la popolazione del genere umano, Robson aveva ritenuto suo dovere morale mantenere costanti i numeri del pianeta. Sotto ogni altro aspetto era nostra opinione che Robson avesse tradito noi e il pensiero responsabile. Il suo gesto era stato non filosofico, egocentrico e scarsamente artistico: in altre parole, sbagliato. Quanto al biglietto di addio sul quale secondo le voci (sempre quella di Brown) era scritto «Scusami, mamma», a noi parve che rinunciasse a cogliere una poderosa opportunità educativa.
Forse saremmo stati meno severi con Robson non fosse stato per un unico fatto cruciale e incontrovertibile: Robson aveva la nostra età, era del tutto ordinario secondo i nostri parametri, e ciononostante non solo era riuscito a trovarsi una ragazza, ma anche a fare, innegabilmente, sesso con lei. Maledetto bastardo! Perché lui e non noi? Come mai a nessuno di noi era successo anche solo di farsi dire di no? Se non altro l’umiliazione avrebbe arricchito la nostra saggezza e ci avrebbe fornito un motivo di orgoglio, seppure di segno negativo. (Le sue esatte parole sono state «Cretino foruncoloso con il fascino di una ciabatta»). Dalle nostre letture dei classici sapevamo che l’Amore comportava Sofferenza e ci saremmo volentieri allenati a Soffrire se ciò avesse comportato la tacita, perfino ragionevole promessa che prima o poi sarebbe arrivato l’Amore.
Ecco un’altra delle nostre paure: che la Vita potesse rivelarsi diversa dalla Letteratura. Prendi i nostri genitori, erano forse materiale letterario? Tutt’al piú, potevano ambire al ruolo di astanti, di spettatori, far parte di un fondale umano contro il quale avvenivano le cose reali, quelle che contano veramente. Tipo? Beh, tutte le cose di cui si occupa la Letteratura: amore, sesso, morale, amicizia, felicità, sofferenza, tradimento, adulterio, bene e male, eroi e cattivi, colpevoli e innocenti, ambizioni, potere, giustizia, rivoluzione, guerra, padri e figli, madri e figlie, l’individuo in rapporto al sociale, il successo e il fallimento, l’omicidio, il suicidio, la morte, Dio. E i gufi reali. Certo, esistevano anche altri generi di letteratura: teorica, autoreferenziale, pietosamente autobiografica; solo sterili seghe mentali, però. L’autentica letteratura trattava delle verità psicologiche, sentimentali e sociali che emergevano dalle azioni e dai pensieri dei protagonisti; il romanzo si fondava sugli sviluppi di un personaggio nel corso del tempo. Cosí almeno ci aveva detto Phil Dixon. E la sola persona – a parte Robson – la cui esistenza contenesse qualcosa di remotamente degno di un romanzo era Adrian.
[...]
La mia ragazza si chiamava Veronica Mary Elizabeth Ford, informazioni (mi riferisco al secondo e terzo nome) che impiegai due mesi a estorcerle. Studiava spagnolo, amava la poesia e suo padre era un funzionario. Un metro e sessanta circa, polpacci forti, capelli castano chiaro lunghi fino alle spalle, occhi grigioazzurri dietro un paio di occhiali dalla montatura azzurra, e un sorriso veloce che non ti lasciava piú andare. La trovavo simpatica. Beh, quasi certamente l’avrei pensato di qualunque ragazza che non mi evitasse. Non provai neanche a dirle che mi sentivo un po’ giú perché non era vero. Aveva un giradischi Black Box (contro il mio Dansette) e gusti musicali migliori dei miei; vale a dire che disprezzava Dvořák e Čajkovskij, che io adoravo, e possedeva alcuni lp di corali e di Lieder. Passava ogni tanto in rassegna la mia collezione di dischi intervallando qualche sorrisetto fugace e una assai piú frequente espressione delusa. Il fatto di avere nascosto sia l’ouverture 1812 sia la colonna sonora di Un uomo, una donna non bastò a salvarmi. Trovò abbastanza materiale di dubbio gusto anche prima di raggiungere la mia vasta raccolta di musica pop: Elvis, i Beatles, i Rolling Stones (e fin qui, nessuno avrebbe trovato nulla da eccepire), ma anche gli Hollies, gli Animals, i Moody Blues e un doppio di Donovan (definito, in caratteri minuscoli, in copertina, il dono di un fiore a un giardino).
– Questa roba ti piace? – mi chiese con voce impassibile.
– Va bene per ballare, – risposi, un po’ sulla difensiva.
– Perché, balli quando l’ascolti? Qui? In camera tua? Da solo?
– No, non proprio –. Ovviamente lo facevo, invece.
– Io non ballo, – disse lei, a metà fra l’antropologa e la responsabile del regolamento di ogni possibile nostro rapporto, qualora fossimo usciti insieme.
Sarà meglio che spieghi il significato dell’espressione «uscire insieme» di allora, perché poi il tempo l’ha modificato. Di recente mi è capitato di parlare con una donna la cui figlia le aveva confidato la propria angoscia. Era al secondo semestre di università e andava a letto con un ragazzo che nello stesso periodo era andato a letto con numerose altre ragazze, in modo esplicito e senza sotterfugi. Il suo obiettivo era selezionarle tramite audizione per poi decidere con quale «uscire». La figlia si diceva sconvolta, non tanto per il sistema – pur intuendone almeno in parte l’iniquità – ma perché alla fine non era risultata lei la prescelta.
Il racconto mi fece sentire come il superstite di una cultura obsoleta e anacronistica, i cui membri utilizzassero ancora rape rosse intagliate al posto della valuta. Ai «miei tempi» – benché non abbia mai vantato diritti d’autore sull’epoca, e meno che mai mi sogni di farlo ora – di solito succedeva cosí: conoscevi una ragazza, lei ti piaceva, cercavi di ingraziartene i favori, la invitavi in un paio di luoghi di incontro – che so io, un pub –, poi le chiedevi di trovarvi da soli, poi glielo chiedevi di nuovo e, dopo un bacio della buonanotte di intensità passionale variabile, potevi ufficialmente dichiarare che «uscivi» con lei. Era solo dopo aver preso un impegno pressoché pubblico che ti era dato di scoprire la sua posizione in materia di comportamento sessuale. Il che qualche volta significava avere a che fare con un corpo protetto come una riserva di pesca esclusiva.
Veronica non era molto diversa dalle altre ragazze di allora. Si mostravano fisicamente disinvolte, ti prendevano sottobraccio in pubblico, ti baciavano da toglierti il fiato, potevano addirittura premerti volutamente addosso il seno, a patto che restassero almeno cinque strati di stoffa tra pelle e pelle. Erano perfettamente consapevoli di quanto accadeva frattanto nei tuoi pantaloni, pur non parlandone mai. E questo era tutto, per un bel po’ di tempo. Certe ti concedevano qualcosa di piú: si sentiva di alcune disposte alla masturbazione reciproca e di altre che ti lasciavano fare «sesso completo», come si diceva allora. Non si era in grado di apprezzare l’importanza di quell’aggettivo «completo», se non si aveva avuto parecchia esperienza del suo contrario, vale a dire dell’incompleto. Infine, con il progredire del rapporto, si verificava una serie di implicite contrattazioni, alcune fondate sul capriccio, altre su impegni e promesse, fino a ciò che il poeta ha chiamato «la lotta per un anello».
Le generazioni successive potrebbero essere inclini a ricercare la causa di tutto nella religione o nel moralismo. Ma le ragazze – o le donne – con le quali ho avuto esperienze di ciò che si potrebbe definire sesso per interposita lana (sí, non c’è stata soltanto Veronica) erano a proprio agio con il loro corpo. Nonché, fatti salvi alcuni principî, anche con il mio. Non intendo suggerire, intendiamoci, che l’interposita lana non fosse eccitante, o che risultasse frustrante, se si esclude l’accezione letterale del termine. Inoltre, quelle ragazze si concedevano assai di piú delle loro madri, e io ottenevo piú di quanto avesse avuto mio padre. O almeno, cosí presumevo. E qualsiasi cosa era sempre meglio di niente. Non fosse che, nel frattempo, Colin e Alex si erano sistemati con ragazze la cui linea di condotta non prevedeva alcuna zona-tabú, o cosí le loro allusioni lasciavano supporre. Del resto, nessuno diceva la verità in fatto di sesso. E sotto questo aspetto non è cambiato nulla.
[...]
Il padre di Veronica afferrò la mia valigia come se ubbidisse a un remoto codice di ospitalità, ed esagerandone comicamente il peso, la trascinò su fino a una mansarda dove la gettò sul letto. Mi indicò un lavello minuscolo a parete e disse:
– Puoi farla lí di notte, se vuoi.
Per tutta risposta annuii. Non capivo se stava sfoggiando un cameratismo virile, o se mi trattava come feccia di ceto inferiore.
Piú facile da interpretare fu Jack, il fratello di Veronica: il classico giovane sano e atletico che ride di quasi tutto e prende in giro la sorella minore. Quanto a me, mi trattava come un oggetto di modesto interesse e sicuramente non il primo a comparire al suo cospetto per una valutazione. La madre di Veronica ignorò tutto il teatrino circostante, mi chiese che cosa studiassi e sparí parecchio in cucina. Doveva avere piú o meno quarant’anni anche se naturalmente a me sembrava di un’abbondante mezza età, come il marito. Non assomigliava molto a Veronica: viso piú largo, fronte alta, capelli legati dietro con un nastro, altezza appena superiore alla media. Aveva un’aria vagamente artistica – saranno state le sciarpe variopinte, o i modi svagati, i motivi d’opera che canticchiava tra sé, o tutte e tre le cose insieme – ma a distanza di tanto tempo non saprei dire con precisione da cosa dipendesse.
Ero talmente a disagio che mi si bloccò l’intestino per tutto il weekend: e questo è il ricordo piú nitido che ho. Il resto è fatto di impressioni e immagini indistinte che potrebbero benissimo essere strumentali: ad esempio, il modo in cui Veronica, dopo avermi invitato, sembrò battere in ritirata e unirsi alla sua famiglia nel sottopormi a esame, anche se, oggi come oggi, mi è difficile stabilire se ciò fosse causa e non conseguenza della mia insicurezza. A tavola quel venerdí cominciarono le domande sulla mia posizione intellettuale e sociale: mi sentivo come un imputato davanti a una commissione d’inchiesta. Dopo cena, guardammo il telegiornale e intavolammo una discussione impacciata sullo stato delle cose nel mondo, fino all’ora di andare a letto. Se fossimo stati in un romanzo, avrebbe potuto verificarsi qualche corsa furtiva tra un piano e l’altro della casa per un appassionato abbraccio dopo che il paterfamilias si fosse ritirato a dormire. Purtroppo non eravamo in un romanzo: Veronica mi negò perfino il bacio della buonanotte, quella prima sera, né accampò la scusa di controllare se avevo gli asciugamani e tutto il necessario. Forse temeva lo scherno del fratello. Perciò mi spogliai, mi lavai, pisciai aggressivamente nel lavandino, misi il pigiama e rimasi sveglio molto a lungo.
Quando scesi per colazione, trovai solo Mrs Ford. Gli altri erano usciti a fare una passeggiata e Veronica aveva assicurato a tutti che io avrei preferito dormire. Non dovetti riuscire a mascherare del tutto la mia reazione, perché mi sentivo addosso lo sguardo di Mrs Ford la quale mi friggeva uova e pancetta con tanto malgarbo che finí per rompere un tuorlo. Non ero un esperto di conversazioni con le madri delle ragazze.
– Abitate qui da parecchio? – chiesi alla fine, pur sapendo già la risposta.
Si fermò per versarsi una tazza di tè, ruppe in padella un altro uovo, si appoggiò a una credenza strapiena di piatti e disse:
– Non dargliele tutte vinte, a Veronica.
Non sapevo come rispondere. Dovevo mostrarmi infastidito per l’ingerenza nel nostro rapporto, o assumere un atteggiamento confidenziale e mettermi a discutere sull’argomento-Veronica? Perciò dissi tutto compito:
– In che senso, Mrs Ford? Mi guardò, sorrise senza paternalismo, scosse appena la testa e disse: – Abitiamo qui da dieci anni.
Insomma, finii per ritrovarmi altrettanto a disagio con la madre come con il resto della famiglia, anche se a lei almeno sembravo piacere. Mi scodellò nel piatto un altro uovo, benché non l’avessi né chiesto, né voluto. Gli avanzi di quello rotto restavano nella padella; li scaricò sovrappensiero in pattumiera e quasi lanciò la padella rovente dentro il lavello bagnato. L’acqua sfrigolò sprigionando una nuvola di vapore, e lei rise come se la divertisse il piccolo trambusto che aveva causato.
Quando Veronica e gli uomini di casa tornarono, mi aspettavo un’ulteriore sessione d’esame, magari perfino un gioco, qualche trabocchetto; ci furono invece domande educate sulla qualità del mio sonno e sul mio generale benessere. Il che avrebbe dovuto farmi sentire accolto, ma avevo piú l’impressione che si fossero stancati di me e che il weekend fosse ormai questione di tempo da far passare. Forse era solo una mia paranoia. Ma a suffragare l’ipotesi, Veronica si mostrava ora piú apertamente affettuosa; a tavola fu lieta di appoggiarmi una mano sul braccio e di scompigliarmi i capelli. A un certo punto si girò verso il fratello e gli disse:
– Allora, può andare, no?
Jack mi strizzò l’occhio; non ricambiai. Una parte di me, in compenso, si sentiva come se avessi rubato gli asciugamani di casa, o calpestato la moquette con le scarpe sporche di fango.
Eppure le cose procedevano perlopiú normalmente. Quella sera Veronica mi accompagnò di sopra e mi concesse un bel bacio della buonanotte. La domenica a pranzo, c’era un arrosto di agnello da cui fuoriuscivano rami di rosmarino grossi come punte d’albero di Natale. Poiché i miei mi avevano insegnato l’educazione, dissi che era squisito. A quel punto colsi l’occhiata ammiccante che Jack rivolse a suo padre, come a dire: Che leccaculo. Ma Mr Ford ridacchiò commentando: – Senti, senti, mozione approvata, concordo, – mentre Mrs Ford mi ringraziava.
Quando scesi per congedarmi, Mr Ford mi prese la valigia e disse: – Hai contato che non manchi niente nell’argenteria, vero cara? – Lei non si prese nemmeno la briga di rispondere, si limitò a sorridermi, quasi come se condividessimo un segreto. Jack non si fece vivo per la cerimonia degli addii; Veronica salí davanti in macchina con suo padre; io mi accomodai dietro di nuovo. Mrs Ford stava appoggiata al portico, e il sole batteva sul glicine che si arrampicava su per la casa al di sopra della sua testa. Quando Mr Ford ingranò la marcia e avviò l’auto sul vialetto di ghiaia, io salutai con la mano e lei ricambiò, ma non come fa la gente di solito, sollevando il palmo, bensí con una specie di gesto orizzontale non oltre l’altezza della cintura. Per un momento, rimpiansi di non averle parlato di piú.Per evitare che Mr Ford tornasse a segnalarmi le meraviglie di Chislehurst, dissi a Veronica: – Mi piace, tua madre.
– Attenta, Vron, sembra che tu abbia una rivale, – disse Mr Ford, trattenendo platealmente il fiato. – Ora che ci penso, forse ho un rivale anch’io. Rivoltelle all’alba, giovinotto?
Il treno era in ritardo a causa dei soliti cantieri aperti la domenica. Arrivai a casa verso sera. Ricordo che mi feci una cacata magistrale.
[...]
All’inizio, cercavo di capire la reazione dei miei amici di fronte a Veronica, ma di lí a poco scoprii che mi interessava di piú sapere che cosa lei pensasse di loro. Rise delle battute di Colin piú che delle mie, il che mi innervosí, e chiese ad Alex come si fosse arricchito suo padre (assicurazioni navali, le disse lui, sorprendendomi). Veronica sembrò contenta di tenersi Adrian per ultimo. Le avevo detto che stava a Cambridge, e gli propose i nomi di una serie di persone. Lui annuí di un paio, dicendo:
– Sí, ho presente il genere.
Mi parve un commento abbastanza antipatico, ma Veronica non si offese. Anzi, continuò a sciorinare nomi di college e di professori e di sale da tè in un modo che mi fece sentire tagliato fuori.
– Come fai a sapere tutte queste cose su Cambridge? – le chiesi.
– Perché ci sta Jack.
– Jack?
– Mio fratello, ti ricordi?
– Aspetta, vediamo… quello piú giovane di tuo padre?
Non mi sembrava male come battuta, ma non la degnò neanche di un sorriso.
– Jack cosa studia? – domandai, cercando di recuperare terreno.
– Filosofia, – rispose. – Come Adrian.
So bene che cosa studia Adrian, grazie tante, avrei voluto ribattere. Invece mi limitai a tenerle il broncio per un po’ e a chiacchierare di cinema con Colin.
Verso la fine del pomeriggio scattammo qualche foto; Veronica ne chiese «una con i tuoi amici». I tre invitati presero educatamente posto in fila, e lei procedette a risistemarli: Adrian e Colin, i due piú alti rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra, con Alex a fianco di Colin. La stampa faceva sembrare lei ancora piú minuta di quanto non fosse di persona. Molti anni dopo, quando tornai a esaminare quella fotografia a caccia di risposte, mi capitò di chiedermi come mai Veronica non portasse mai tacchi di nessuna misura. Avevo letto da qualche parte che, se uno vuole farsi ascoltare dagli altri, non deve alzare la voce, bensí abbassarla; è questo che suscita autentica attenzione. Forse Veronica utilizzava lo stesso espediente per la statura. Benché non abbia ancora capito se Veronica fosse tipo da fare ricorso a espedienti. Nel periodo in cui uscivamo insieme, mi è sempre sembrato che agisse d’impulso, senza premeditazione. D’altra parte io mi rifiutavo di considerare l’ipotesi che una donna volesse o potesse manipolare gli altri. E questo forse la dice piú lunga su di me che su di lei. Ma anche qualora dovessi decidere, con il senno di molto tempo dopo, che Veronica fosse sempre stata un tipo machiavellico, non credo che questo aiuterebbe a chiarire le cose. O meglio, non credo che aiuterebbe me.
[...]
Non voglio dare l’impressione di non aver fatto altro che sgobbare e vedere Veronica, a Bristol. E tuttavia riaffiora ben poco alla mia memoria. Un evento che torna, isolato e distinto, però, è la sera in cui assistetti al fenomeno della marea del Severn. Di solito, il giornale locale pubblicava un orario, indicando luoghi e tempi migliori per non mancarla. Ma la prima volta che ci provai, l’acqua sembrava decisa a infischiarsene delle istruzioni. Poi, una sera a Minsterworth, un gruppetto di noi si mise in attesa in riva al fiume fino a dopo mezzanotte, quando la nostra costanza fu ripagata. Per un paio d’ore ci toccò stare a guardare un fiume scorrere docile verso il mare come ogni buon corso d’acqua. I fugaci bagliori lunari erano coadiuvati dalle perlustrazioni saltuarie di alcune potenti torce elettriche. A un certo punto ci fu un mormorio, un generale protendersi di colli e ogni fastidio mentale prodotto dal freddo e dall’umidità svaní; sembrava che il fiume avesse semplicemente cambiato idea e un’onda alta poco meno di un metro venne verso di noi, frangendosi per la sua intera ampiezza, da una sponda all’altra. Il flutto montò fino alla nostra postazione, ci superò e piegò in lontananza; alcuni dei miei compagni si lanciarono all’inseguimento tra urla, imprecazioni e cadute, mentre l’onda in corsa li distaccava; io rimasi a riva, da solo. Non credo di riuscire a trasmettere l’impatto che quel momento ebbe su di me. Non fu come assistere a un uragano o a un terremoto (esperienze che, peraltro, non conosco), cioè a una natura che si fa violenta e distruttiva, richiamandoci tutti all’ordine. Fu perfino piú allarmante, perché i sensi lo percepirono come un quieto errore, come se qualcuno avesse azionato una minuscola leva nell’universo e in quel luogo preciso, per pochi minuti, la natura e il tempo procedessero a rovescio. Osservato col buio, inoltre, il fenomeno diventava ancora piú arcano, ancora piú surreale.
[...]
Poi mi alzai e mi diressi in bagno, col guanto pieno che mi sbatacchiava contro l’interno coscia. Mentre me ne disfacevo presi una decisione che si concludeva cosí: No, proprio no.
– Sei un bastardo egoista, – mi disse, quando ci rincontrammo.
– Sí, beh, le cose stanno cosí.
– In pratica è stato uno stupro, allora.
– Io proprio non credo.
– Beh, avresti potuto usarmi la cortesia di dirmelo prima.
– Non lo sapevo neanch’io, prima.
– Oh, è stato uno schifo cosí totale?
– No, è stato bello. Solo che…
– Solo che?
– Tu mi chiedevi sempre di riflettere sul nostro rapporto e adesso forse l’ho fatto. Sí.
– Beh, complimenti. Deve essere stata dura.
Io intanto pensavo: E non le ho nemmeno visto le tette, in tutto questo tempo. Sentite, sí, le ho sentite, ma viste, mai. E poi si sbaglia di grosso su Dvořák e Čajkovskij. Senza contare che io potrò sentirmi il mio lp di Un uomo, una donna finché mi pare. E non di nascosto.
– Come, scusa?
– Cristo, Tony, ma non riesci nemmeno a concentrarti ora? Aveva ragione mio fratello su di te.
Sapevo che dovevo chiedere che cosa avesse detto Fratello Jack, ma non volevo darle la soddisfazione. Visto che non fiatavo, lei proseguí:
– E non dire quello che si dice sempre.
La vita era tutta un indovinello, anche piú del solito.
– E sarebbe?
– Che possiamo continuare a essere amici.
– È previsto che dica cosí?
– È previsto che tu dica quello che pensi, quello che provi, Cristo santo, quello che ti pare.
– D’accordo. In tal caso, non dirò quel che è previsto io dica, perché non credo che possiamo continuare a essere amici.
– Perfetto, – commentò lei sarcastica. – Perfetto.
– Ma c’è una domanda che ti voglio fare. Sei venuta a letto con me per riconquistarmi?
– Non sono piú tenuta a rispondere alle tue domande.
– In tal caso, perché non sei venuta a letto con me mentre stavamo insieme?
Nessuna risposta.
– Perché non era necessario?
– Forse perché non ne avevo voglia.
– Forse non ne avevi voglia perché non era necessario.
– Beh, credi pure quel che ti pare.
Il giorno dopo, portai la lattiera che mi aveva regalato al negozio dell’usato. Speravo che la vedesse in vetrina. Quando però mi fermai a guardare, notai un altro articolo esposto in vendita: una piccola litografia a colori di Chislehurst che le avevo regalato io per Natale.
[...]
E la logica? Già, dove sta la logica? Dove si trova, ad esempio, nel successivo passaggio della mia storia? A metà circa dell’ultimo anno di studi, ricevetti una lettera da Adrian. Era diventato un fatto sempre piú raro, perché tutti e due stavamo sgobbando in vista della laurea. Nel suo caso, probabilmente a pieni voti. Dopodiché? Un dottorato, quasi di certo, poi la carriera accademica o qualche incarico nella pubblica amministrazione che gli permettesse di mettere a frutto cervello e senso di responsabilità. Una volta qualcuno mi disse che la pubblica amministrazione (perlomeno ai massimi livelli) era un ambiente di lavoro affascinante perché costringeva a continue decisioni di tipo etico. Forse una soluzione adatta a uno come Adrian. Di sicuro non me lo vedevo diventare una persona pratica delle cose del mondo, né intraprendente, se non a livello intellettuale, s’intende. Non era il genere di persona di cui trovi il nome o la faccia pubblicati sui giornali.
Probabilmente avrete capito che prendo tempo per non dirvi il seguito. D’accordo: Adrian mi scrisse per chiedermi il permesso di uscire con Veronica.Già, perché lei? perché in quel momento? e soprattutto, perché chiedere? In effetti, a voler essere fedeli al ricordo, ammesso che ciò sia possibile (e non ho conservato nemmeno questa, di lettera), in realtà Adrian diceva che lui e Veronica già uscivano insieme, circostanza senza dubbio destinata a giungere prima o poi alle mie orecchie; e della quale pertanto riteneva meglio essere lui stesso a informarmi. Aggiungeva poi che, sebbene la notizia potesse suscitare la mia sorpresa, si augurava che l’avrei accolta con serenità, perché in caso contrario, dato il nostro legame di amicizia, avrebbe dovuto riprendere in considerazione il suo gesto e le sue iniziative. E infine, che Veronica aveva acconsentito alla stesura di quella lettera; che anzi l’aveva parzialmente suggerita.
Come potete immaginare, mi piacque il passaggio sugli scrupoli morali, quello in base al quale, se a mio giudizio fosse stato infranto un sacro codice cavalleresco o, meglio ancora, un principio etico moderno, Adrian, in ossequio alla logica, avrebbe ovviamente smesso di scoparsela. Sempre a patto che lei non lo stesse menando per il naso come aveva fatto con me. Mi piacque inoltre l’ipocrisia di una lettera il cui scopo non era soltanto quello di ragguagliarmi in merito a qualcosa che avrei potuto non scoprire mai (o per parecchio tempo), ma farmi anche sapere quanto ci avesse guadagnato Veronica, ora che stava con il piú intelligente dei miei amici, e per di piú studente a Cambridge come Fratello Jack. Infine, che me la sarei ritrovata fra i piedi, se avevo intenzione di vedere Adrian, il che ebbe su di me l’effetto auspicato di farmi scegliere l’opzione opposta, e cioè di non rivedere Adrian. Niente male, per un’unica giornata, o nottata, di lavoro. Devo tuttavia sottolineare ancora una volta come questa sia la mia lettura attuale dei fatti. O meglio, l’attuale ricordo della mia lettura di allora di quanto al tempo accadeva.
Credo tuttavia di avere attitudine alla sopravvivenza, all’autoconservazione. Forse è questo che Veronica chiamava codardia e io definivo essere pacifici. In ogni caso, qualcosa mi suggerí che era meglio non lasciarmi coinvolgere, non subito, almeno. Comprai la prima cartolina che capitava – una col ponte sospeso di Clifton – e scrissi un testo del tipo: «Facendo seguito alla tua del 21 c.m., il sottoscritto è lieto di porgerti le sue piú sentite congratulazioni e dichiararsi perfettamente felice dell’accaduto, vecchio mio». Cretino, ma inequivocabile; il che, per il momento, poteva bastare. Avrei finto, soprattutto con me stesso, di non avere assolutamente nulla in contrario. Mi sarei sepolto a studiare, avrei messo da parte i sentimenti, senza portarmi piú a casa nessuno dal pub, masturbandomi quando e come necessario e preoccupandomi di arrivare alla laurea che meritavo. E cosí feci (a proposito, sí, senza giocarmi i pieni voti).
Mi trattenni un paio di settimane dopo gli esami, presi a frequentare compagnie diverse, mi ubriacai sistematicamente, fumai un po’ di erba e cercai di pensare il meno possibile. A parte immaginare quello che Veronica poteva aver detto di me a Adrian («Prima si è preso la mia verginità e subito dopo mi ha buttata via. Capisci perché mi sono sentita violentata?») Mi pareva di vederla, mentre se lo lisciava – ero stato testimone dell’inizio di quel percorso – lusingandolo e facendo leva sulle sue ambizioni. Come ho già detto, Adrian non era un uomo pratico delle cose del mondo, a dispetto di tutto il suo successo accademico. Da ciò dipendeva il tono saccente della sua lettera che, per qualche tempo, continuai a rileggermi con vittimistica soddisfazione. Quando, alla fine, mi decisi a rispondere seriamente, feci a meno di tutto quel cretino formulario epistolare. Per quanto ricordo, gli chiarii in modo abbastanza diffuso il mio punto di vista sugli scrupoli morali suoi e di lei. Gli suggerii inoltre di stare all’erta perché, a mio giudizio, la violazione subita da Veronica risaliva a molto tempo prima. Dopodiché gli augurai buona fortuna, bruciai la sua lettera su una graticola vuota (un gesto melodrammatico, sono d’accordo, ma invoco la mia giovinezza a circostanza attenuante) e decretai che quei due erano usciti dalla mia vita per sempre.
[...]
Che cosa intendevo con il termine «violazione»? Era una semplice congettura, non disponevo di prove certe. Eppure, se ripensavo a quel nostro malaugurato weekend, mi rendevo conto che non si era trattato solo di un giovane ingenuo a disagio in un ambiente familiare piú raffinato e socialmente disinvolto del suo. C’era stato anche quello, senza dubbio. Ma avevo percepito una complicità tra Veronica e quel suo genitore privo di tatto e delicatezza, che mi trattava come un sottosviluppato. Come pure tra Veronica e Fratello Jack, la cui vita e il cui contegno lei reputava in modo palese insuperabili: era lui il giudice incaricato al quale Veronica rivolse pubblicamente la domanda su di me – una domanda che assume connotazioni piú umilianti ogni volta che me la ripeto: «Allora, può andare, no?» Non vedevo in compenso la minima complicità con la madre, che senza dubbio conosceva sua figlia per quello che era. Come mai Mrs Ford aveva avuto quella prima opportunità di mettermi in guardia dalla figlia? Perché la mattina, la mattina immediatamente successiva al mio arrivo, Veronica aveva raccontato a tutti che io volevo dormire, e se n’era andata a spasso con padre e fratello. Niente che ci fossimo mai detti poteva giustificare una frottola simile. Io non dormivo mai fino a tardi. Non lo faccio nemmeno ora.
Mentre scrivevo a Adrian, non ero sicuro io stesso di quel che potevo intendere con il termine «violazione». E a quasi un’intera vita di distanza, il concetto non mi è poi molto piú chiaro. Mia suocera (che per fortuna non ha un ruolo in questa vicenda) non mi ha mai stimato granché, ma è sempre stata se non altro molto sincera sul punto, come su quasi ogni cosa. Ebbene, mia suocera una volta mi disse, commentando l’ennesimo caso di abuso infantile che dominava le pagine dei quotidiani e i telegiornali: – Secondo me, siamo stati tutti vittime di un abuso –. Sto forse insinuando che Veronica sia stata vittima di quello che al giorno d’oggi definiremmo «comportamento improprio»: occhiate lascive di un padre con l’alito che sapeva di birra mentre lei faceva il bagno o si spogliava per andare a letto, qualcosa di piú di una fraterna intimità fisica con il fratello? Come farei a saperlo? Ci sarà stato nella sua vita un episodio di abbandono primario, una mancanza di affetto quando piú che mai ne aveva bisogno, uno scambio di battute sentito per caso e dal quale la bambina abbia dedotto che…? Di nuovo, non posso saperlo. Non dispongo di prove aneddotiche né documentali. In compenso, ricordo che cosa disse il vecchio Joe Hunt durante una discussione con Adrian: che le condizioni mentali delle persone possono essere dedotte dai loro gesti. Varrà per la Storia, Enrico VIII e compagnia bella. Mentre nella vita privata, penso sia vero il contrario: e cioè che sia possibile comprendere i gesti passati delle persone, attraverso le loro condizioni mentali presenti.
Di sicuro sono convinto anch’io che tutti subiamo violazioni, in un modo o nell’altro. Come potrebbe non essere cosí, se non in un mondo fatto di genitori, fratelli, amici e vicini di casa perfetti? Esiste poi la questione, dalla quale cosí tanto dipende, di come ciascuno di noi reagisce alla violazione subita: se la riconosce o la nega, e come essa influisca sui rapporti con gli altri. Qualcuno ammette che sia avvenuta, e cerca di mitigarne gli effetti; qualcuno passa la vita ad aiutare altri che l’hanno subita; e poi c’è qualcuno il cui fine primario è arginare violazioni ulteriori, a ogni costo. Questi ultimi sono la categoria piú spietata, quella da cui guardarsi.
Potete anche pensare che siano solo sciocchezze, castronerie moralistiche, strategia di autoassoluzione. Potete ritenere che il mio atteggiamento nei confronti di Veronica sia stato da classico maschio inesperto, e che tutte le mie «conclusioni» siano controvertibili. Ad esempio, «Dopo esserci lasciati, Veronica venne a letto con me» si può agevolmente ribaltare in «Dopo che Veronica venne a letto con me, la lasciai». Potete inoltre decidere che i Ford fossero una normale famiglia borghese. Sulla quale ho riversato astiosamente fasulli teoremi di violazione; e che Mrs Ford, anziché preoccuparsi con grande sensibilità del mio benessere, rivelasse un’indecorosa invidia verso la propria figlia. Potreste addirittura chiedermi di applicare a me stesso la mia «teoria» e di raccontarvi quale violazione abbia subíto io molto tempo prima, precisandone le eventuali conseguenze; ad esempio in materia di affidabilità e di schiettezza. Non sono sicuro che saprei rispondervi, a essere onesto.
[...]
Con l’andare degli anni, ti aspetteresti un po’ di riposo, no? Sei convinto di meritartelo. Io lo pensavo, almeno. Poi però cominci a capire che la vita non promuove per merito.
Un’altra cosa: da giovane credi di saper prevedere probabili angosce e dolori della vecchiaia. Ti immagini solo, divorziato, vedovo; coi figli cresciuti che se ne vanno, gli amici che muoiono. Immagini che perderai prestigio, desiderio e desiderabilità. Puoi spingerti oltre e considerare l’avvicinarsi della tua stessa morte che, a dispetto di qualunque compagnia tu riesca a radunarti intorno, dovrai comunque affrontare da solo. Ma tutto questo ha a che fare con il guardare avanti. Quello che ti è impossibile è guardare avanti e immaginare te stesso che guarda indietro dal punto che avrai raggiunto nel futuro. Conoscere le emozioni nuove portate dal tempo. Scoprire, ad esempio, che con il ridursi del numero di testimoni della tua esistenza tende a diminuire l’avvaloramento, e di conseguenza la certezza, di ciò che sei o sei stato. Se anche hai documentato ogni cosa in modo sistematico, in forma di immagini, suoni, parole, puoi d’improvviso scoprire di aver sbagliato le modalità di registrazione dei fatti. Com’era la battuta di Adrian? «La storia è quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze della documentazione».
Leggo ancora parecchia storia e, va da sé, mi sono tenuto al corrente sui grandi eventi contemporanei alla mia vita: la caduta del Comunismo, la signora Thatcher, l’11 settembre, il riscaldamento globale. L’ho fatto con il normale miscuglio di ansia, paura e cauto ottimismo. Ma senza mai riuscire a considerarli con la stessa fiduciosa sicurezza con la quale guardo ai fatti di storia greca e romana, o dell’Impero britannico, o della Rivoluzione sovietica. Può darsi che mi senta piú tranquillo con la storia sulla quale si è ormai grossomodo raggiunto un accordo. O forse si tratta ancora una volta del vecchio paradosso: la storia che ci succede sotto il naso dovrebbe essere per noi la piú chiara, e invece risulta la piú deliquescente. Viviamo nel tempo, il tempo ci definisce e ci vincola e dovrebbe anche essere misura della storia, no? Ma se non riusciamo a comprenderlo, se non ne afferriamo il mistero in termini di andamento e decorso, che speranze possiamo avere con la storia, perfino con il marginale frammento della nostra personale, peraltro assai poco documentata?
Quando si è giovani, chiunque superi i trent’anni ci sembra di mezza età, chiunque superi i cinquanta, decrepito. E il passare del tempo ci conferma che non sbagliavamo di molto. Le piccole differenze d’età, cosí significative e palesi da giovani, perdono rilevanza. Si finisce con l’appartenere alla stessa grande famiglia, quella dei non-piú-giovani. Personalmente non ci ho mai badato granché.
Esistono tuttavia alcune eccezioni alla regola. Per qualcuno le differenze temporali sancite in gioventú non spariscono mai completamente: i maggiori d’età restano tali, anche quando si è ormai tutti dei vecchi bavosi. Per certa gente, una differenza di, che so, cinque mesi, significa che uno dei due continuerà a ritenersi perversamente piú saggio ed esperto dell’altro o dell’altra, a dispetto di qualunque prova contraria. O dovrei forse dire a causa di prove contrarie. Proprio perché risulta del tutto ovvio a qualsiasi osservatore obiettivo che l’equilibrio si è spostato in favore dell’individuo irrisoriamente piú giovane, l’altro rivendica la propria presunta superiorità con rigore ancor piú draconiano. Ancor piú nevrotico.
[...]
5.4 Il problema dell’accumulo. Se la vita è una scommessa, quale forma assume la giocata? Nell’ambiente ippico, si chiama sistema ad accumulo una giocata che trasferisce le vincite ottenute su un cavallo alla puntata sul successivo pronostico.
5.5 Pertanto a) Fino a che punto è possibile definire le relazioni umane in base a una formula logica o matematica? E b) Qualora sia possibile, quali segni dovremo sistemare tra i numeri interi? Il piú e il meno, tautologicamente; talvolta il per e, sí, anche il diviso. Ma questi segni hanno un limite. Cosí facendo, una relazione completamente fallimentare potrebbe essere espressa sia in termini di perdita/meno sia di riduzione/diviso, arrivando a un risultato pari a zero; mentre una relazione riuscita può essere rappresentata come addizione e moltiplicazione. Ma che dire della maggior parte delle altre? Non hanno forse bisogno di esprimersi in termini improbabili sotto il profilo logico e irresolubile sotto quello matematico?
5.6 Pertanto, come potremmo esprimere un accumulo che contenga gli interi b, a1, a2, s, v?
b = s – vx+ a1
oppure a2 + v + a1 × s = b?
5.7 O si tratta forse di un approccio errato alla questione e alla rappresentazione dell’accumulo? Applicare i principî della logica alla condizione umana è forse in sé e per sé un sistema destinato al fallimento? Che cosa accade in una catena di argomenti quando ogni anello è fatto di metalli dotati di frangibilità diverse?
5.8 E se «anello» fosse una metafora non applicabile?
5.9 Ma supponendo che invece lo sia, se un anello si spezza, come si rintraccia la causa di tale rottura? Osservando gli anelli immediatamente vicini al punto di rottura, oppure «l’intera catena»? Ma cosa intendiamo per l’intera catena? Quanto si estendono i limiti della responsabilità?
6.0 Oppure potremmo ridurre il campo di analisi delle responsabilità e distribuirle in modo piú esatto. E non utilizzare equazioni e numeri interi, bensí esprimere la questione facendo ricorso alla tradizionale terminologia narrativa. Dunque, ad esempio, se Tony
[...]
Ricordo un periodo verso la fine dell’adolescenza in cui mi ubriacavo mentalmente di prospettive avventurose. Ecco come sarò da adulto. Andrò in quel paese, farò questo, scoprirò quello, mi innamorerò di lei, e poi di lei, di lei e di lei. Vivrò come da sempre vive la gente nei romanzi. Quali romanzi, non mi era chiaro, ma sapevo per certo che passione e pericolo, estasi e disperazione (ma sempre seguita da altra estasi, intendiamoci) non sarebbero mancati. Comunque… chi è che ha parlato della «piccolezza delle passioni che l’arte ingigantisce»? Ci fu un momento quando ero ormai prossimo ai trenta, in cui dovetti riconoscere lo spegnersi definitivo di ogni ipotesi avventurosa. Non avrei mai attuato le imprese sognate da ragazzo. In compenso, tosavo il prato di casa, andavo in vacanza, facevo la mia vita.
Il tempo però… ah, come può trascinarci alla deriva e confonderci le idee. Credevamo di aver raggiunto la maturità quando ci eravamo soltanto messi in salvo, al sicuro. Fantasticavamo sul nostro senso di responsabilità, non riconoscendolo per quello che era, e cioè vigliaccheria. Ciò che abbiamo chiamato realismo si è rivelato un modo per evitare le cose, ben piú che affrontarle. Già, il tempo ci riserva… il tempo necessario a farci percepire le nostre piú salde risoluzioni come traballanti, le nostre certezze come capricci momentanei.
[...]
Sin dal principio, lui aveva visto le cose con piú chiarezza. Mentre noi ci crogiolavamo nella malinconia adolescenziale convinti che la nostra scontentezza quotidiana potesse essere una reazione originale al male di vivere, Adrian già guardava oltre, spaziando su orizzonti piú vasti. E sentiva anche piú di noi la vita – perfino quando, o forse soprattutto quando, giunse alla conclusione che il gioco non valeva la candela. In confronto a lui ero sempre stato un confusionario, incapace di imparare quelle poche lezioni che l’esistenza mi aveva impartito. Per dirla in parole mie, mi ero adeguato alla realtà della vita, sottomettendomi all’ineluttabile: se cosí, allora colà, ed erano passati gli anni. Per usare invece le parole di Adrian, avevo rinunciato a vivere, avevo smesso di analizzare la vita per prenderla come veniva. Cosí, per la prima volta, ho cominciato a provare un rimorso piú vasto – un sentimento a metà tra il vittimismo e l’odio per me stesso – riguardo alla mia esistenza in generale. Tutta quanta. Avevo perso gli amici di gioventú. Avevo perso l’amore di mia moglie. Avevo rinunciato ai sogni di una volta. Avevo chiesto alla vita di non turbarmi troppo ed ero stato accontentato; e che miseria ne era derivata.
Nella media, ecco come sono dai tempi del liceo. Medio all’università e sul lavoro; medio in amicizia, lealtà e amore; medio, senza dubbio, anche nel sesso. Qualche anno fa è uscito un sondaggio sugli automobilisti inglesi in base al quale il novantacinque per cento degli intervistati si riteneva un guidatore «al di sopra della media». In effetti, in ossequio alla statistica, la maggior parte di noi rientra per forza nella media. Non che questo rechi il minimo conforto. L’aggettivo echeggia sinistro. Medio nella vita, nella verità; moralmente nella media. La prima reazione di Veronica, vedendomi, era stata di sottolineare che avevo perso i capelli. Ma quello era il meno.
La mail che mi ha spedito in risposta alle mie scuse diceva: «Proprio non ci arrivi, eh? Come sempre, del resto». Non potevo certo recriminare. Anche se mi sono ritrovato a rimpiangere pateticamente che non avesse usato il mio nome almeno in una delle due frasi.
[...]
Il carattere delle persone si sviluppa nel tempo? Nei romanzi, naturalmente, sí: altrimenti non ci sarebbe storia. Ma nella vita? A volte me lo chiedo. Cambiano i nostri atteggiamenti, le nostre opinioni, assumiamo nuove abitudini e nuove bizzarrie; ma è un’altra cosa, un fatto piú decorativo. Forse il carattere è simile all’intelligenza, anche se raggiunge il suo picco massimo leggermente piú tardi, diciamo, tra i vent’anni e i trenta. Dopodiché, non ci schiodiamo piú da lí. Siamo soli. Se cosí fosse, si spiegherebbero parecchie esistenze, non vi pare? Nonché, se il termine non risulta troppo solenne, la nostra tragedia.
«Il problema dell’accumulo», aveva scritto Adrian. Scommetti dei soldi su un cavallo, quello vince e la vincita passa sul cavallo della corsa successiva, e cosí via. Le vincite si accumulano. E le perdite? Non all’ippodromo, dove si perde solo la puntata iniziale. Ma nella vita? Forse in questo caso le regole sono diverse. Scommetti su una relazione, non funziona; vai alla successiva, e non funziona neanche quella; forse non perdi solo la somma di due sottrazioni, bensí un multiplo di quanto avevi puntato. L’impressione è questa, comunque. La vita non è solo fatta di somme e sottrazioni. C’è anche l’accumulo, la moltiplicazione delle perdite, dei fallimenti.
Il frammento del diario di Adrian fa anche cenno alla questione della responsabilità, domandandosi se collocarla in una catena o considerarla separatamente. Sono decisamente propenso alla seconda soluzione. No, mi dispiace, non puoi prendertela con i tuoi genitori defunti, o con il fatto di avere avuto fratelli e sorelle, o di non averne avuti, o con la genetica, o la società, o chissà che altro: non in circostanze normali, almeno. Parti dal principio di essere l’unico e solo responsabile, a meno di avere prove schiaccianti del contrario. Adrian era molto piú intelligente di me – lui usava la logica dove io ricorro al buonsenso – ma credo che alla fine siamo giunti entrambi alla stessa conclusione.
Non che io riesca a capire tutto quel che ha scritto, intendiamoci. Ho contemplato a lungo le equazioni sul suo diario senza sentirmi particolarmente illuminato. D’altra parte, la matematica non è mai stata il mio forte.
A Adrian non invidio la morte, ma la trasparenza della vita. Non solo perché vedeva, pensava, sentiva e agiva con piú chiarezza rispetto a tutti noi, ma anche per il momento in cui è morto. Non mi riferisco alle tirate retoriche da Grande Guerra, tipo «Reciso nel fiore degli anni» – espressione ancora rispolverata dal nostro preside in occasione del suicidio di Robson – o «Essi non saranno vecchi a differenza di noi, rimasti sulla terra a invecchiare». La maggior parte di noi rimasti non ha avuto nulla in contrario con l’idea di invecchiare. Sempre meglio dell’alternativa, secondo me. No, voglio dire un’altra cosa. Che quando hai vent’anni, pur essendo confuso e dubbioso sulle tue mire e aspirazioni, hai comunque forte il senso di cosa sia la vita e di cosa tu sia o possa diventare, in quella vita. Dopo… beh, dopo ci sono piú incertezze, piú sovrapposizioni, marce indietro, falsi ricordi. Da giovane sei in grado di ricordarti la tua breve esistenza tutta intera. Piú tardi la memoria si riempie di toppe e brandelli. È un po’ come la scatola nera degli aerei, che registra quel che accade in caso di incidente. Se non succede nulla, il nastro si cancella da sé. Perciò, se davvero precipiti, è chiaro perché l’hai fatto; ma se non vai giú, allora il giornale di bordo del tuo viaggio si fa assai meno limpido.
Oppure, per metterla in un altro modo. Qualcuno una volta ha detto che i suoi periodi storici preferiti erano quelli in cui tutto precipita, perché significano la nascita imminente di qualcosa di nuovo. Ha senso questa teoria se la applichiamo alle vite dei singoli individui? Morire quando sta per nascere qualcosa di nuovo, anche se la novità in questione riguarda proprio noi? Perché, esattamente come ogni cambiamento storico o politico prima o poi delude, cosí succede con il diventare adulti. Con la vita. Certe volte penso che lo scopo dell’esistenza sia quello di riconciliarci, per sfinimento, con la sua perdita finale, dimostrandoci che, indipendentemente dal tempo che ci vorrà, la vita non è affatto all’altezza della propria fama.
[...]
Prima in confidenza consideravo che la caratteristica essenziale del rimorso è che non ci si può fare niente: perché il tempo delle scuse e delle ammende è passato da un pezzo. E se mi sbagliassi, invece? E se si potesse, chissà come, sospingere il rimorso controcorrente, trasformarlo in semplice senso di colpa, quindi chiedere scusa e ottenere il perdono? E se uno potesse dimostrare che in fondo non era il bastardo per cui era stato scambiato, e lei fosse disposta a lasciarsi persuadere?
O forse le mie motivazioni arrivavano dalla direzione opposta, e non c’era di mezzo il mio passato, bensí il mio futuro. Come quasi tutti, ho alcune superstizioni collegate con le partenze per un viaggio. Possiamo anche sapere che volare è piú sicuro che andare a piedi fino al negozio d’angolo, ma prima di partire preferiamo pagare le bollette, sbrigare la corrispondenza, telefonare a una persona cara.
[...]
Quando si comincia a dimenticare le cose – non mi riferisco all’Alzheimer, ma solo alle prevedibili conseguenze dell’età – si può reagire in vari modi. Ci si può mettere d’impegno e cercare di costringere la memoria a cacciare fuori il nome di quel conoscente, di quel fiore, quella stazione ferroviaria, quell’astronauta… Oppure si può ammettere la propria défaillance e prendere misure pratiche al riguardo, utilizzando testi di consultazione e internet. O piú semplicemente, si può lasciar perdere – infischiarsene di ricordare – e scoprire, a volte, che l’elemento smarrito riaffiora magari a distanza di un’ora o di un giorno, spesso nel corso di quelle interminabili notti insonni che la vecchiaia infligge. È una cosa che impariamo tutti, tutti quelli di noi che dimenticano, intendo.
Ma impariamo anche qualcos’altro, e cioè che al nostro cervello non piace che gli si attribuisca un ruolo fisso. Proprio quando crediamo che sia tutta una questione di decrescita, di sottrazioni e divisioni, ecco che la nostra mente, la nostra memoria, possono sorprenderci. Quasi a dirci: Non pensare di poter fare conto su un rassicurante processo di graduale declino – la vita è molto piú complicata di cosí. E allora il cervello si mette a lanciarti addosso brandelli di cose, perfino a sbrogliare certi ben noti grovigli della memoria. E, con mio grande sgomento, è proprio questo che mi stava capitando. Ho cominciato a ricordare, in ordine sparso e senza un particolare senso di logica, dettagli sepolti da molto tempo di quel lontano weekend in casa Ford. La mia stanza in mansarda affacciava, dai tetti, su un bosco; di sotto sentivo una pendola battere le ore con cinque minuti esatti di ritardo. Mrs Ford rovesciò l’uovo rotto in pattumiera con aria turbata, per l’uovo, non per me. Il marito cercò di convincermi a bere un brandy dopo cena e, dato il mio rifiuto, mi chiese se ero un uomo o un sorcio. Fratello Jack si rivolgeva a Mrs Ford chiamandola «la Madre», in espressioni del tipo: «Quando ha intenzione di pensare al rancio per le truppe affamate, la Madre?» E la seconda sera Veronica non si limitò a venire con me fino al piano di sopra. Disse: – Accompagno Tony in camera sua, – e mi prese per mano davanti a tutti. Fratello Jack disse: – Che ne pensa la Madre? Non ha niente da dire? – Ma la Madre si limitò a sorridere. Quella sera diedi una frettolosa buonanotte a tutta la famiglia, perché sentivo un’erezione in arrivo. Salimmo piano fino in camera da letto, dove Veronica, sbattendomi contro la porta, mi baciò sulla bocca e poi disse: – Dormi il sonno dei depravati, stanotte –. E grossomodo quaranta secondi dopo, ricordo ora, mi masturbavo dentro il piccolo lavello fiottando sperma nell’impianto idraulico della casa.
Per curiosità, ho cercato Chislehurst su Google. E ho scoperto che non c’era mai stata una chiesa dedicata a St Michael, da quelle parti. Perciò il giro guidato del centro offertomi in macchina da Mr Ford doveva essere frutto della fantasia – una specie di scherzo segreto, un modo per sfottermi… Ho forti dubbi anche sull’effettiva presenza di un Café Royal. A quel punto sono andato su Google Earth, e mi sono dedicato ad acrobazie e perlustrazioni ravvicinate del sobborgo, ma la casa che stavo cercando pareva non esistere piú.
[...]
Ho trascorso la settimana sforzandomi di recuperare nuovi ricordi su Veronica, ma non è riemerso nulla. Forse a insistere cosí mettevo sotto pressione il mio cervello. Perciò alla fine sono tornato a passare in rassegna quel che avevo, le ben note immagini di sempre e le recenti acquisizioni. Le piazzavo sotto la luce, rigirandomele tra le dita e cercando di capire se avessero frattanto cambiato significato. Ho cominciato a riesaminare me stesso da giovane, risalendo il piú indietro possibile. Certo, ero stato rozzo e ingenuo, come tutti in fondo; ma sapevo di non dover premere troppo su quel tasto, perché avrebbe avuto il solo scopo di incensare il me stesso che ero diventato. Ho cercato di mantenermi oggettivo. La versione del mio rapporto con Veronica che mi portavo appresso da anni era rimasta quella che mi conveniva allora. Un giovane cuore tradito, un giovane corpo usato come un giocattolo, un giovane individuo mortificato dal paternalismo di classe. Come aveva risposto il vecchio Joe Hunt quando con aria saccente avevo dichiarato che la storia era fatta delle menzogne dei vincitori? «Non dimentichi comunque che è fatta anche delle illusioni dei vinti». Ce ne ricordiamo abbastanza quando sono in gioco le nostre vite private?
I giovanilisti compulsivi sostengono: i quaranta non sono nulla, a cinquanta si è nel fiore degli anni, i sessanta sono i quaranta del giorno d’oggi. Io so una cosa per certo: che un tempo oggettivo esiste, ma che esiste anche quello soggettivo, quello che si porta sull’interno polso, proprio accanto alle pulsazioni cardiache. E questo tempo personale, che è poi anche quello autentico, si misura in funzione del nostro rapporto con i ricordi. Perciò, quando è accaduta quella cosa strana, e all’improvviso mi sono ritrovato invaso da una serie di ricordi nuovi, è stato come se, per un attimo, il tempo avesse ingranato la retromarcia. Come se, per un attimo, il fiume risalisse la corrente.
Read more...