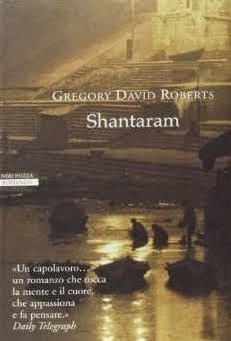L'ultima estate - Cesarina Vighy
>> domenica 23 ottobre 2011
Un opera d'arte si giudica tenendo in considerazione la biografia del suo autore? Secondo me, no. Il valore della musica di Mozart prescinde dalla considerazione che il compositore era un irriverente, maleducato libertino. Ho letto il libro della Vighy ignorando la sua storia (lo ha scritto nel 2009 all'età di 73 anni quando già era gravemente ammalata di SLA). La trama è molto esile ed è in realtà il pretesto per trascrivere una serie di considerazioni autobiografiche che nella maggior parte dei casi mi hanno annoiato. Meritano quelle che trascrivo di seguito. Tanto di cappello, però, alla scrittrice per la forza di volontà e lucidità con cui è riuscita a strappare alla sua terribile malattia lo spazio per testimoniare una vita difficile e piena di dolore.
Se ho accennato a questi viaggi, che ora tutt'al più vengono organizzati per vecchie pensionate cui rifilare pentole, non è solo per nostalgia, sentimento che certo mi accomuna a quelle tali vecchie pensionate, ma per la sensazione soffocante di oggi che il mondo si stia restringendo, viaggi compresi, fino a stritolarti. No, non è il lamento di chi trova bello tutto ciò che riguarda la propria giovinezza, un'età che fa molto soffrire, ma è un fatto concreto, constatabile da chiunque voglia pensarci un po' su: dai diecimila nomi usati una quarantina d'anni fa si è passati a tremila, dell'infinita varietà di mele si salvano appena le renette, le golden e poche altre. E dove si trova un pezzo di stoffa o un bottone rosa antico, pavone, turchese, azzurro polvere, verde Nilo? Chi ha ancora davanti agli occhi della mente, precise, queste fragili sfumature? SOS: salvate le nostre anime!
[...]
E' autunno fondo ormai. La pioggia cade ad aghi fini fini, dimostrando ancora una volta quanto sia più elegante l'argento dell'oro. Goethe scriveva che chi non sa più meravigliarsi del mutare delle stagioni è un uomo finito. Finalmente siamo in autunno pieno, da poesia per libro delle elementari: pioggia, ultime foglie secche che non si sa cosa stiano a fare attaccate al loro albero, bambini mogi dal risveglio difficile dopo il primo entusiasmo per le cartelle e i libri nuovi.
Scomparsi la meraviglia dorata dell'inizio, l'uva multicolore, gli ultimi fichi, le prime castagne. Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni! Ma in fondo, solo io posso godermi la pioggia, da dietro un vetro, senza il pensiero di rovinarmi le scarpe, i capelli, le giornate.
[...]
In verità sono stata una moglie mediocre, di carne fredda, e soprattutto una madre manchevole. Le cattive figlie diventano cattive madri perché vogliono dare il contrario di quanto hanno ricevuto e quindi sbagliano due volte. Mandai la mia piccola a una scuola ambitissima che praticava lo snobismo alla rovescia: sita in una landa desolante, accanto a una fabbrica che produceva veleno per topi, tutto il suo sessantottismo consisteva nel rifiutare fermamente le tabelline. Non le parlai mai di dio e di religioni: risultato, scambiava - e scambia tuttora - Mosè con Noè. La lasciai crescere insomma come un cavallino selvaggio, convinta che la natura le avrebbe insegnato la via e invece quella, maligna e matrigna com'è, le ha spostato continuamente i segnali stradali, confondendola e impaurendola.
[...]
Ogni matrimonio è un mistero, gaudioso o doloroso (mai glorioso), noto solo ai due sposi: mistero che noi, invece, continuiamo a ignorare. Avevamo tutto contro. Attratta sempre, per via del mio Edipo, da uomini fatti e talora anche sfatti, convinta che avessero molto da insegnarmi, sposavo un ragazzo di sette anni più giovane, di famiglia semplice e con nessuna voglia di capire il mio mondo e tanto meno di entrarci. Quanto alla famiglia semplice, mi detestava come fossi una vecchia maliarda che si prendeva il suo figlio migliore per usarlo e poi buttarlo via. Tutti ci davano al massimo uno o due anni per arrivare al divorzio. Invece, siamo ancora qui, insieme, dopo quarant'anni. Miracolo? Ai miracoli non credo. Piuttosto, al di là della stima, l'affetto, l'amore, si crea spesso un legame inestricabile, una simbiosi, tra oscuri bisogni che cercano, e spesso trovano, un sollievo, una compensazione in quelli dell'altro. Ora so cosa cercavo io. Un alibi. Un alibi che giustificasse il mio scarso successo, il mio negarmi alla creatività, alle buone frequentazioni, alle amicizie, alle novità. Lo trovai facilmente nella gelosia di lui: una gelosia cupa, morbosa, da siciliano, che mi legava mani e piedi e che io accettavo perché mi liberava dall'obbligo di riconoscere nella paura di non farcela, di essere giudicata, la radice dello scacco matto che mi assegnavo prima ancora di cominciare la partita. Eppure, eccoci qua: io malatissima, lui, l'angelo incazzoso, solerte come una madre che indovina i desideri del suo bambino prima ancora di sentirglieli esprimere. Eccoci qua dopo anni di quiete che si potrebbero chiamare anni felici se solo sapessimo, mentre la si vive, che quella è la felicità. Da qualche giorno, da qualche notte, perdo facilmente il respiro, mi pare di soffocare, immagino cosa si prova ad annegare. Il mio sapientissimo medico (anzi professore con anni di studio, pubblicazioni su riviste internazionali, convegni importanti) mi ha detto serio serio: «Provi a mettere un cuscino di più nel letto».
[...]
Dentro, era tutto uno splendere di detersivi: un vero peccato, in fondo, che ospitasse solo dei malati. Lì imparai a districarmi in quel piccolo mondo chiuso, dove sono in vigore altri usi, altre abitudini, altre leggi. Cominciai a osservare le divise, cui di solito diamo un'occhiata talmente distratta da ricordare appena se si trattasse di camici o di casacche. Distinzione importantissima, invece, perché rivela gerarchie e ascese nella scala sociale: il camice bianco spetta solo ai medici e a chiunque abbia la qualifica di capo; l'azzurro-verde e le casacche sono per gli altri. Benché tutte le divise vengano accuratamente descritte e prescritte nei regolamenti interni (scollo a V, tre bottoni, tasche sovrapposte, pantaloni unisex), la vanità, l'individualismo e i troppo frequenti lavaggi antimacchia, che sbiadiscono colori e bordini, rendono inutile il fine per cui sono nate facendoci scambiare spesso un generale per un caporale. L'importante, in ogni caso, è capire dove sta il potere: nei portantini e nelle capo sala. I primi possono bloccare il meccanismo che fa funzionare l'intero ospedale; le seconde, fiduciarie e portavoce dei medici ma insieme provenienti dalla stessa classe sociale dei sottoposti, ne conoscono gli umori e quindi sanno dosare a perfezione bastone e carota. Quanto ai terapisti, possono essere grosso modo divisi in due categorie: i semplici e i composti. I semplici badano a far bene il loro lavoro, hanno un equo rapporto col denaro e la loro aspirazione massima è la laurea triennale che, a parer loro, li innalzerebbe quasi all'altezza dei veri dottori. I composti sono più inquieti, più spirituali, e svolgono spesso il loro compito come una missione salvifica per i malati e per se stessi, il che non è detto che sia sempre il meglio. La mia logopedista era così: simpatica, intelligente, amante della poesia e del teatro. Naturalmente, passavamo quasi tutta l'ora destinatami a chiacchierare dimenticando i palloncini da gonfiare e le cannucce da succhiare. Veniva da molte esperienze dolorose, tra cui un tentato suicidio. Aspiranti suicidi, attenzione! In questa fase iniziale, trionfalistica, per chi non abbia remore religiose sembra la soluzione ideale per evitare, alzando la mano su di sé, che altri (chi?) sia più svelto ad alzarla. Così, con uno scatto di dignità da antico romano, ce ne possiamo andare liberi, senza assistere e offrire spettacolo di troppa degradazione. Quando eravamo molto giovani (e solo questo ci scusa), mio marito e io avevamo progettato questa uscita di sicurezza, sull'esempio di molte coppie socialiste dell'Ottocento. Non ci mettemmo d'accordo solo perché, data la differenza di età tra noi, non ci sapevamo decidere a quale anno della vita avremmo dovuto mettere fine. Brigitte Bardot, nell'era del musetto imbronciato e della coda di cavallo, aveva detto una bestialità più grossa ancora: che si sarebbe suicidata a trent'anni. Oggi è una gattara spettinata quanto me. Attenti, compagni di sventura che ormai siete i destinatari di questo piccolo vademecum che si va componendo quasi da solo. L'homo sapiens è l'animale più adattabile che sia mai comparso, senza scomparire, sulla faccia della terra. Via i dinosauri, via i mammuth ma l'essere umano è sempre qui. Perché si è piegato, senza pregiudizi ma non senza disgusto, a mangiar carne o erba, secondo le carestie. Quando credeva di essere civilizzato perché parlava, camminava dritto e si vestiva, magari di una giacchetta a strisce con una stella gialla cucita sopra, ha mangiato bucce di patate, spazzatura, cuoio bollito. Altri, diversi, hanno tradito, venduto i figli, prostituito le figlie, per sopravvivere. Alla fine si accetta tutto, credete a me che odio la bruttezza, la sporcizia, la dipendenza dagli altri, la malattia e, sì, anche i malati: l'umiliante istinto di sopravvivenza ha la meglio. Read more...
Se ho accennato a questi viaggi, che ora tutt'al più vengono organizzati per vecchie pensionate cui rifilare pentole, non è solo per nostalgia, sentimento che certo mi accomuna a quelle tali vecchie pensionate, ma per la sensazione soffocante di oggi che il mondo si stia restringendo, viaggi compresi, fino a stritolarti. No, non è il lamento di chi trova bello tutto ciò che riguarda la propria giovinezza, un'età che fa molto soffrire, ma è un fatto concreto, constatabile da chiunque voglia pensarci un po' su: dai diecimila nomi usati una quarantina d'anni fa si è passati a tremila, dell'infinita varietà di mele si salvano appena le renette, le golden e poche altre. E dove si trova un pezzo di stoffa o un bottone rosa antico, pavone, turchese, azzurro polvere, verde Nilo? Chi ha ancora davanti agli occhi della mente, precise, queste fragili sfumature? SOS: salvate le nostre anime!
[...]
E' autunno fondo ormai. La pioggia cade ad aghi fini fini, dimostrando ancora una volta quanto sia più elegante l'argento dell'oro. Goethe scriveva che chi non sa più meravigliarsi del mutare delle stagioni è un uomo finito. Finalmente siamo in autunno pieno, da poesia per libro delle elementari: pioggia, ultime foglie secche che non si sa cosa stiano a fare attaccate al loro albero, bambini mogi dal risveglio difficile dopo il primo entusiasmo per le cartelle e i libri nuovi.
Scomparsi la meraviglia dorata dell'inizio, l'uva multicolore, gli ultimi fichi, le prime castagne. Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni! Ma in fondo, solo io posso godermi la pioggia, da dietro un vetro, senza il pensiero di rovinarmi le scarpe, i capelli, le giornate.
[...]
In verità sono stata una moglie mediocre, di carne fredda, e soprattutto una madre manchevole. Le cattive figlie diventano cattive madri perché vogliono dare il contrario di quanto hanno ricevuto e quindi sbagliano due volte. Mandai la mia piccola a una scuola ambitissima che praticava lo snobismo alla rovescia: sita in una landa desolante, accanto a una fabbrica che produceva veleno per topi, tutto il suo sessantottismo consisteva nel rifiutare fermamente le tabelline. Non le parlai mai di dio e di religioni: risultato, scambiava - e scambia tuttora - Mosè con Noè. La lasciai crescere insomma come un cavallino selvaggio, convinta che la natura le avrebbe insegnato la via e invece quella, maligna e matrigna com'è, le ha spostato continuamente i segnali stradali, confondendola e impaurendola.
[...]
Ogni matrimonio è un mistero, gaudioso o doloroso (mai glorioso), noto solo ai due sposi: mistero che noi, invece, continuiamo a ignorare. Avevamo tutto contro. Attratta sempre, per via del mio Edipo, da uomini fatti e talora anche sfatti, convinta che avessero molto da insegnarmi, sposavo un ragazzo di sette anni più giovane, di famiglia semplice e con nessuna voglia di capire il mio mondo e tanto meno di entrarci. Quanto alla famiglia semplice, mi detestava come fossi una vecchia maliarda che si prendeva il suo figlio migliore per usarlo e poi buttarlo via. Tutti ci davano al massimo uno o due anni per arrivare al divorzio. Invece, siamo ancora qui, insieme, dopo quarant'anni. Miracolo? Ai miracoli non credo. Piuttosto, al di là della stima, l'affetto, l'amore, si crea spesso un legame inestricabile, una simbiosi, tra oscuri bisogni che cercano, e spesso trovano, un sollievo, una compensazione in quelli dell'altro. Ora so cosa cercavo io. Un alibi. Un alibi che giustificasse il mio scarso successo, il mio negarmi alla creatività, alle buone frequentazioni, alle amicizie, alle novità. Lo trovai facilmente nella gelosia di lui: una gelosia cupa, morbosa, da siciliano, che mi legava mani e piedi e che io accettavo perché mi liberava dall'obbligo di riconoscere nella paura di non farcela, di essere giudicata, la radice dello scacco matto che mi assegnavo prima ancora di cominciare la partita. Eppure, eccoci qua: io malatissima, lui, l'angelo incazzoso, solerte come una madre che indovina i desideri del suo bambino prima ancora di sentirglieli esprimere. Eccoci qua dopo anni di quiete che si potrebbero chiamare anni felici se solo sapessimo, mentre la si vive, che quella è la felicità. Da qualche giorno, da qualche notte, perdo facilmente il respiro, mi pare di soffocare, immagino cosa si prova ad annegare. Il mio sapientissimo medico (anzi professore con anni di studio, pubblicazioni su riviste internazionali, convegni importanti) mi ha detto serio serio: «Provi a mettere un cuscino di più nel letto».
[...]
Dentro, era tutto uno splendere di detersivi: un vero peccato, in fondo, che ospitasse solo dei malati. Lì imparai a districarmi in quel piccolo mondo chiuso, dove sono in vigore altri usi, altre abitudini, altre leggi. Cominciai a osservare le divise, cui di solito diamo un'occhiata talmente distratta da ricordare appena se si trattasse di camici o di casacche. Distinzione importantissima, invece, perché rivela gerarchie e ascese nella scala sociale: il camice bianco spetta solo ai medici e a chiunque abbia la qualifica di capo; l'azzurro-verde e le casacche sono per gli altri. Benché tutte le divise vengano accuratamente descritte e prescritte nei regolamenti interni (scollo a V, tre bottoni, tasche sovrapposte, pantaloni unisex), la vanità, l'individualismo e i troppo frequenti lavaggi antimacchia, che sbiadiscono colori e bordini, rendono inutile il fine per cui sono nate facendoci scambiare spesso un generale per un caporale. L'importante, in ogni caso, è capire dove sta il potere: nei portantini e nelle capo sala. I primi possono bloccare il meccanismo che fa funzionare l'intero ospedale; le seconde, fiduciarie e portavoce dei medici ma insieme provenienti dalla stessa classe sociale dei sottoposti, ne conoscono gli umori e quindi sanno dosare a perfezione bastone e carota. Quanto ai terapisti, possono essere grosso modo divisi in due categorie: i semplici e i composti. I semplici badano a far bene il loro lavoro, hanno un equo rapporto col denaro e la loro aspirazione massima è la laurea triennale che, a parer loro, li innalzerebbe quasi all'altezza dei veri dottori. I composti sono più inquieti, più spirituali, e svolgono spesso il loro compito come una missione salvifica per i malati e per se stessi, il che non è detto che sia sempre il meglio. La mia logopedista era così: simpatica, intelligente, amante della poesia e del teatro. Naturalmente, passavamo quasi tutta l'ora destinatami a chiacchierare dimenticando i palloncini da gonfiare e le cannucce da succhiare. Veniva da molte esperienze dolorose, tra cui un tentato suicidio. Aspiranti suicidi, attenzione! In questa fase iniziale, trionfalistica, per chi non abbia remore religiose sembra la soluzione ideale per evitare, alzando la mano su di sé, che altri (chi?) sia più svelto ad alzarla. Così, con uno scatto di dignità da antico romano, ce ne possiamo andare liberi, senza assistere e offrire spettacolo di troppa degradazione. Quando eravamo molto giovani (e solo questo ci scusa), mio marito e io avevamo progettato questa uscita di sicurezza, sull'esempio di molte coppie socialiste dell'Ottocento. Non ci mettemmo d'accordo solo perché, data la differenza di età tra noi, non ci sapevamo decidere a quale anno della vita avremmo dovuto mettere fine. Brigitte Bardot, nell'era del musetto imbronciato e della coda di cavallo, aveva detto una bestialità più grossa ancora: che si sarebbe suicidata a trent'anni. Oggi è una gattara spettinata quanto me. Attenti, compagni di sventura che ormai siete i destinatari di questo piccolo vademecum che si va componendo quasi da solo. L'homo sapiens è l'animale più adattabile che sia mai comparso, senza scomparire, sulla faccia della terra. Via i dinosauri, via i mammuth ma l'essere umano è sempre qui. Perché si è piegato, senza pregiudizi ma non senza disgusto, a mangiar carne o erba, secondo le carestie. Quando credeva di essere civilizzato perché parlava, camminava dritto e si vestiva, magari di una giacchetta a strisce con una stella gialla cucita sopra, ha mangiato bucce di patate, spazzatura, cuoio bollito. Altri, diversi, hanno tradito, venduto i figli, prostituito le figlie, per sopravvivere. Alla fine si accetta tutto, credete a me che odio la bruttezza, la sporcizia, la dipendenza dagli altri, la malattia e, sì, anche i malati: l'umiliante istinto di sopravvivenza ha la meglio. Read more...